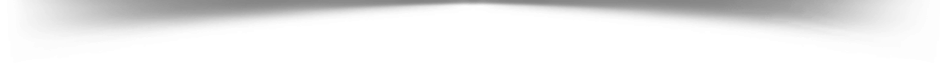Inaugurazione Ponte San Giorgio
- DATE 12 Gen , 2021
- Author: sara
- COMMENTS Leave a comment
Solo una piccola riflessione sul nuovo #pontemorandi.
I vigili del fuoco non parteciperanno all’inaugurazione.
Le famiglie delle 43 vittime nemmeno.
Questo dovrebbe bastare a far comprendere l’opportunità dei festeggiamenti.
E a distinguere i due piani fondamentali della questione: l’inaugurazione, evitabile in questa forma, dalla ricostruzione e dalla commemorazione.
Da troppi mesi – che ormai sono diventati anni, due per la precisione – intorno alla ricostruzione del ponte gira troppa propaganda politica, troppa ricerca di consenso, troppa sicumera del “guardate come siamo stati bravi a ridare a Genova il ponte di cui aveva bisogno”.
È vero, Genova ha bisogno come l’aria del nuovo ponte, e nessuno, giuro, nessuno vuole mettere in discussione questo assunto di base.
Nessuno vuole restare ancorato al passato e tutti abbiamo voglia di andare avanti e guardare al futuro, ma non si può dimenticare l’impatto emotivo che questa tragedia ha avuto su Genova e sui suoi cittadini, con un’eco mondiale.
Io ricordo, nei giorni successivi al crollo, decine di mail di clienti da tutto il mondo, dall’India agli Stati Uniti, passando per gli Emirati Arabi e il Sud America, che mi scrivevano per assicurarsi che stessimo bene, per avere notizie perché quell’evento era arrivato fino a lì.
Ma noi genovesi guardando il nuovo skyline, facciamo fatica a riconoscerlo.
Abbiamo ancora negli occhi quel “ponte di brooklyn” che veniva persino studiato sui libri di architettura, e a quell’immagine si sovrappone quella del cumulo di macerie, quella dei vigili del fuoco esausti dopo ore incessanti di lavoro di scavo nella speranza – flebile tanto da essere vana – di trovare qualche superstite lottando contro il tempo e contro il maltempo, perché quella mattina diluviava, e non se lo scorda nessuno.
Vigili del fuoco che hanno avuto bisogno di supporto psicologico importante per superare il trauma dell’orrore in cui hanno dovuto scavare a mani nude.
Abbiamo negli occhi quel camion verde della Basko appeso sul bordo del baratro in cui siamo caduti tutti, quel giorno terribile di agosto.
Abbiamo nei polmoni le polveri dei giorni seguenti, e dei mesi seguenti dovute agli scavi e alla rimozione delle macerie, e ai gas di scarico della viabilità impazzita, dei camion che finivano puntualmente in sopraelevata, dei tir persi in città seguendo i navigatori impazziti.
Abbiamo nel cuore gli sfollati che hanno dovuto abbandonare un pezzo enorme di vita nelle loro case, che hanno recuperato un pezzo alla volta, chiusa in 50 scatole, con l’ausilio dei vigili del fuoco.
Abbiamo nelle orecchie la preghiera dell’Imam il giorno dei funerali, e le voci delle proteste degli abitanti ai confini della zona rossa.
E avremo per sempre a fianco a noi i 43 morti, vittime di un sistema malato e corrotto che oggi vogliono spacciare per “modello genova”.
Il ponte doveva essere ricostruito in tre mesi, poi in sei, e alla fine sono diventati due anni.
Un tempo record, se pensiamo alle lungaggini e alla burocrazia italiana.
Un tempo infinito per chi vive in questo inferno
Quindi, quello che chiedevamo in tanti, era un po’ di sobrietà, di rispetto per questo dolore che non si sanerà mai, e vale per tutti, ognuno con la propria storia, ognuno col proprio lutto da vivere ed elaborare.
Quello che tuttora molti cittadini chiedono a gran voce, è di essere ascoltati, nelle esigenze quotidiane, nelle cose apparentemente banali, come la scelta del nome di quel ponte, imposto invece dall’alto, come un trofeo, un simbolo di vittoria, quando a noi bastava un nome che ci ricordasse ogni giorno da dove arriva questo nuovo ponte, la sua storia, per quanto tragica, che non deve essere dimenticata per non essere ripetuta.
Solo stringendoci, accettando questo dolore, attraversandolo insieme, potremo pensare di ricostruire davvero.
Allora sì, saremo pronti per guardare avanti e per ripartire insieme.
- Tagged: , inaugurazione, Ponte Morandi, Ponte San Giorgio
- POSTED IN Blog
Tag
- fiducia
- musica
- vita da single
- vita
- 8 marzo
- Guerra
- Inverno
- winter
- Torino
- immigrazione
- Salone del libro
- burian
- frozen
- freddo
- Collaborazioni
- figli
- Pilates
- Bullismo
- Sport
- Benessere
- Ghost
- Film
- Alluvione
- Halloween
- Anni '90
- Moda
- Parigi
- Nonna
- Mostre
- discr
- violenza
- 25 Novembre
- andrà
- valigie
- gabbia
- camminare
- il corpo del
- G8
- incipit
- partenze
- tiger
- ridere
- decathlon
- dormire
- inizi
- fine
- mestruazioni
- love
- 11 settembre
- relaz
- rivoluzione
- politica
- social
- Gli invisibili
- aborto
- festa del papà
- black lives matter
- gabbiere
- felicità
- happinessa
- andràtuttobene
- Immuni
- Buenos Aires
- Migranti
- Letture
- maschere
- Serie TV
- Settembre
- Blog
- Ricordi
- amicizia
- Storie di Donne
- pregiudizi
- Pubblicità
- san Valentino
- Amsterdam
- Diritti
- paura
- ragazzi
- inaugurazione
- mare
- il corpo delle donne
- Ponte San Giorgio
- femminismo
- Ballate
- New York
- Anno Nuovo
- Libri
- Figli senza diritti
- Bellezza
- scrittura
- travelling
- lockdwon
- pride
- Morte
- Natale
- Famiglie arcobaleno
- DAD
- Gender
- Attualità
- Tempo
- Arte
- Racconti
- Ponte Morandi
- omofobia
- razzismo
- Vacanze
- monamour
- scuola
- covid
- Famiglia
- Genova
- Estate
- omosessualità
- lockdown
- Viaggi
- A come amiche
- Bambini
- Donne
- coronavirus
- quarantena
- D come donna
- Discriminazione
- Amore
- Maternità
- Lifestyle
- Relazioni
Articoli recenti
Categorie
×